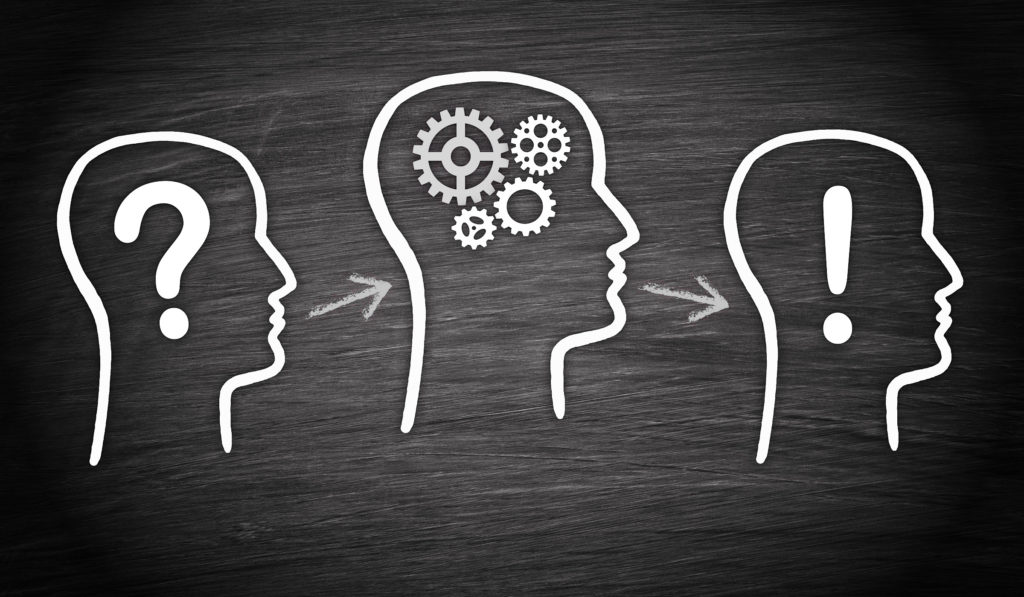
2019
GIORGIO MOCAVINI
Il populismo è oggi al centro del dibattito pubblico e scientifico. I clamorosi risultati elettorali ottenuti da movimenti populisti in varie parti del mondo, dall’Europa occidentale a quella orientale, dall’America Latina agli Stati Uniti e all’Asia, hanno indotto a interrogarsi sulle cause del trionfo populista e su che cosa si intenda con il concetto di «populismo». I fattori che hanno favorito la diffusione dei populismi in anni recenti sono numerosi e vi si possono annoverare: la globalizzazione, che ha reso fluidi i confini nazionali e ha garantito un primato dell’economia sulla politica; l’innovazione tecnologica, che rivoluziona costantemente le modalità di lavoro e di comunicazione; la crescita dei flussi migratori, che pongono una serie di sfide in materia di integrazione; la crisi economica, che ha duramente colpito le classi meno abbienti delle democrazie occidentali, mettendo oltretutto a rischio le conquiste del welfare State; l’acuirsi delle diseguaglianze sociali e di reddito; la progressiva perdita di sovranità degli Stati a vantaggio di organizzazioni internazionali o regionali, come l’Unione europea, ritenute prive di un’adeguata legittimazione democratica.
Se vi è un certo accordo sulle ragioni sottese all’affermazione transnazionale del populismo negli ultimi anni, ancora molto discussa, al contrario, resta la nozione. Questo perché il populismo non è un fenomeno né recente, né tanto meno unitario. «[Per «complesso di Cenerentola»] intendo quanto segue: che esiste una scarpa – la parola «populismo» – per la quale da qualche parte esiste un piede». Così scriveva Isaiah Berlin (citato da M. Tarchi, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna, il Mulino, 2015, 2° ed., 27) per spiegare il sentimento di frustrazione derivante dalla difficoltà di racchiudere il populismo entro un’unica definizione onnicomprensiva. I problemi definitori, comunque, non hanno impedito una copiosa fioritura di studi che hanno messo in evidenza le principali caratteristiche del populismo. Questo assume i contorni di una ideologia (P. Taggart, Populism, Philadelphia, Pa., Open University Press, 2000, trad. it., Il populismo, Troina, Città aperta, 2002) o di uno stile politico (P. A. Taguieff (a cura di), Le retour du populisme. Un défi pour les démocraties européennes, Parigi, Universalis, 2004) che promuove una visione salvifica del popolo in contrasto con le classi dirigenti politiche e finanziarie delle società, accusate di essere corrotte e di curare i propri interessi senza badare al bene comune (I. Diamanti e M. Lazar, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Roma-Bari, Laterza, 2018). In questa prospettiva, il populismo rifiuta le strutture istituzionali della democrazia rappresentativa in favore di un costante e diretto appello al popolo, soggetto politico infallibile e depositario della verità assoluta (M. Canovan, Populism, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1981). La sfiducia nei confronti dei politici di professione e della tradizionale linea di divisione politica tra destra e sinistra, spesso genericamente qualificata come «antipolitica», non di rado sfocia nella ricerca di un leader in grado di farsi portavoce dell’autentica volontà popolare (Y. Mény e Y. Surel (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, Londra, Palgrave Macmillan, 2002). Se questi sono i tratti essenziali del populismo, le esperienze storiche, tuttavia, hanno dimostrato che le compagini populiste, pur appartenendo a una famiglia comune, avanzano proposte e propugnano programmi che possono essere anche molto differenti, tanto che risulta impossibile una effettiva reductio ad unitatem del fenomeno.
Accanto alle domande relative a che cosa sia il populismo e a quali siano le cause scatenanti del suo successo attuale, è forse giunto il momento di porsi un nuovo quesito. A fronte del fatto che il populismo odierno non pare essere un fenomeno destinato a esaurirsi nel breve periodo, ci si può chiedere a quali cambiamenti le democrazie andranno incontro per effetto dell’azione, del linguaggio, del pensiero e del metodo dei movimenti populisti. Questi ultimi hanno ormai monopolizzato la scena politica e in alcuni Paesi sono da tempo stabilmente forze di governo. Il populismo danneggerà le democrazie, favorendo torsioni illiberali, plebiscitarie o autoritarie, oppure queste ultime usciranno più rafforzate dalla «prova» populista alla quale sono sottopose?
È questo il dubbio di fondo che anima il libro di Yves Mény, che si pone in dialogo ideale con l’altro importante volume scritto quasi venti anni fa con Yves Surel (Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocraties, Parigi, Fayard, 2000, trad. it., Populismo e democrazia, Bologna, il Mulino, 2001). In particolare, per comprendere le origini del populismo, per spiegarne la diffusione attuale in gran parte del mondo, per valutare gli effetti che esso produce nei sistemi liberaldemocratici, l’Autore sviluppa una serie di riflessioni che vanno molto al di là del populismo e abbracciano i concetti generali di democrazia, liberalismo, popolo, nazione e tecnocrazia. L’analisi dei vari significati assunti da queste nozioni e della loro diversa combinazione nel corso del tempo permette di cogliere aspetti essenziali delle relazioni tra populismo e democrazia che altrimenti resterebbero nell’ombra o sarebbero inevitabilmente oggetto di semplificazioni.
L’Autore, dunque, prende le mosse dall’idea di democrazia: «il linguaggio politico non conosce che quest’unica parola per descrivere esperienze multiformi, spesso ambigue, sempre imperfette, suscettibili di interpretazioni differenti o contraddittorie» (p. 23). Le istituzioni e le procedure democratiche, in particolare, sono in continua evoluzione. Il modello stesso di democrazia ha subito costanti trasformazioni in virtù di differenti esperienze storiche. Gli attuali sistemi democratici, dunque, sono il risultato di «un lungo bricolage» (p. 43) nel quale si sono fusi apporti di varia provenienza: Atene ha fornito l’ideale della sovranità popolare; Roma ha inventato la forma repubblicana e la separazione dei poteri; l’Inghilterra ha contribuito con il principio della rappresentanza e con il liberalismo; la Francia ha elaborato i diritti dell’uomo e il concetto di sovranità nazionale; la Germania ha sviluppato il Rechsstaat e le politiche sociali; gli Stati Uniti hanno garantito l’indipendenza della magistratura e il controllo di costituzionalità delle leggi; i Paesi Bassi hanno introdotto le nozioni di pluralismo e tolleranza; ecc.
Ne risulta che l’idealtipo democratico è «un work in progress permanente» (p. 47) o «un unfinished business, una mappa relativamente bianca da riempire via via in base a esplorazioni e scoperte» (p. 47), dal momento che «la democrazia non è stata partorita, come Atena armata di tutto punto, dalla testa di Giove» (p. 27), ma è stata costruita attraverso tentativi, aggiustamenti ed errori, ed è stata, di volta in volta, adattata a necessità contingenti.
Ciò che il modello ha sempre conservato come nucleo essenziale in tutte le sue varianti è il particolare ruolo attribuito al popolo, fonte prima da cui scaturisce ogni potere. Il concetto di «popolo», tuttavia, è tanto ricco di sfumature e di accezioni quanto quello di «democrazia». In origine, infatti, il popolo «designa unicamente una parte della popolazione, quella giudicata come la più numerosa, la meno ricca, la più ignorante, la meno degna e la meno capace di svolgere alte funzioni di governo» (p. 68) e, per molto tempo, questo termine è stato sinonimo di vocaboli dispregiativi come «plebe», «popolino», «massa» e «folla». Dopo la Grecia e la Roma repubblicana, dove comunque il popolo indicava l’insieme di cittadini maschi liberi, occorre attendere la rivoluzione americana perché il popolo torni a rivestire un ruolo politico di primo piano. Il popolo è, in astratto, il titolare della sovranità, ma, in concreto, esso è molto circoscritto: non fanno parte del popolo sovrano gli schiavi e le donne. Le moderne democrazie, quindi, nascono col paradosso di fare discendere tutti i poteri dal popolo, escludendovi però una serie di categorie sociali, come i meno abbienti e gli analfabeti, attraverso tecniche istituzionali come il suffragio ristretto e censitario. Si consuma, dunque, una scissione tra popolo astratto e popolo concreto: per tutto il corso del diciannovesimo secolo, si diffida di quest’ultimo e dei suoi eccessi, si ha timore dell’oclocrazia, si inventano regole e procedure per scongiurare la tirannia della maggioranza.
È in questa ottica che viene elaborato il liberalismo. Mény ricorda che esso nasce «come argine alla democrazia» (p. 129), per «moderare le pulsioni maggioritarie» (p. 142) e realizzare un complesso di garanzie individuali sottratte alla disponibilità del leviatano popolare. Perfino la fortuna dell’idea di «nazione», durante l’Ottocento, può essere compresa alla luce del fatto che essa rappresenta una categoria concettuale che supera i dislivelli sociali di ciascun popolo per spostare l’attenzione sulle contrapposizioni etniche: «l’eliminazione delle differenze interne di carattere sociale spinge alla creazione di differenze di tipo spaziale, etnico, culturale. La negazione delle barriere interne rafforza le frontiere esterne» (p. 75). La democrazia, tuttavia, proprio grazie alla sua natura di bricolage permanente, ha saputo conciliarsi tanto con il liberalismo, quanto con la nazione. Dal liberalismo la democrazia ha appreso le esigenze di tutela delle libertà individuali e del pluralismo nell’agone politico, difendendo i diritti delle minoranze contro i potenziali soprusi della maggioranza. Ne deriva, oggi, che un ordinamento illiberale non può essere considerato democratico. Negli Stati-nazione, poi, la democrazia ha trovato la propria culla, nella quale ha potuto svilupparsi a tal punto che si fatica a riconoscere come democratico un sistema politico non ancorato a una dimensione nazionale.
Tuttavia, se da un lato la democrazia si è rivelata tanto duttile e flessibile da incorporare limiti, garanzie e freni con cui imbrigliare il popolo sovrano, dall’altro essa sembra essersi sempre più allontanata dall’ideale governo del popolo per il popolo. I vincoli giuridici, nel perfezionare le democrazie, hanno al contempo ridotto la libertà di azione del popolo. Ciò è positivo, dato che il popolo non può essere onnipotente e che, anzi, «la tentazione dell’illimitata democrazia corre il rischio di corrompere la stessa democrazia. Il «fondamentalismo democratico» e le smisurate ambizioni democratiche rischiano di favorire decisioni popolari ma dannose» (S. Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Milano, Mondadori, 2017, 55). Allo stesso tempo, tuttavia, la moltiplicazione dei vincoli costituzionali, la presenza di autorità non elette a cui dovere rendere conto e il ricorso ai tecnici per lo svolgimento di funzioni pubbliche sono stati avvertiti come un tradimento della promessa di un governo autenticamente popolare e si è da più parti criticata l’ossificazione di gruppi di potere oligarchici (M. L. Salvadori, Democrazie senza democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2011).
Dalla distanza tra la retorica di tutto il potere al popolo e il funzionamento concreto dei meccanismi democratici, secondo l’Autore, scaturisce un profondo sentimento di delusione: «la frustrazione nasce dal fossato, talvolta dall’abisso, che è sempre esistito ed esiste ancora fra il mondo incantato della democrazia sognata e l’universo concreto della politica e del governo» (p. 26). Il vero «malinteso democratico», dunque, risiede nel ridurre la democrazia solo ed esclusivamente al significato di «governo del popolo». Su questa disillusione provocata da così alte aspettative si innesta il populismo. L’Autore ripercorre brevemente l’evoluzione di tale concetto e critica, da una parte, coloro che ne contestano il valore esplicativo e interpretativo, data l’incerta definizione («è un atteggiamento che mi pare esagerato e ingiusto. Rifiutiamo forse la nozione di «Parlamento» o «partito»? Sicuramente no, eppure non ci sono quasi punti di contatto tra il Parlamento britannico, quello della Corea del Nord o del Sudan» p. 155), dall’altra, coloro che lo hanno frettolosamente assimilato a una corrente di estrema destra, risparmiandosi analisi più rigorose. Seguendo l’impostazione di Albert O. Hirschman (Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970, trad. it., Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato, Bologna, il Mulino, 2017), per l’Autore «il populismo, in origine, è innanzitutto e soprattutto una protesta» (p. 161), ossia un particolare tipo di voice. L’attuale «esplosione populista» (p. 164) è da ascrivere a tre tipi di cause, che sono strutturali, sostanziali e procedurali. Le prime sono da ricercare nel collasso dell’Unione Sovietica: la paura del comunismo ha cessato di guidare le scelte politiche di molti elettori. Le seconde vanno individuate nella «crescente divergenza tra politica (elezioni, programmi, istituzioni) e politiche pubbliche in Europa e, in particolare, in seno all’Unione europea» (p. 170). L’azione dei governi democraticamente eletti, infatti, è sempre più influenzata da norme sovranazionali e deve spesso passare al vaglio di altre autorità tecnocratiche. Le terze, infine, concernono i meccanismi elettorali. Nella crisi della politica tradizionale ai movimenti populisti è risultato agevole incanalare la rabbia popolare in occasione di elezioni amministrative e di referendum. Le tornate elettorali considerate secondarie sono state in realtà un trampolino di lancio per i futuri successi di molti movimenti populisti.
Davanti alla netta affermazione del populismo, secondo Mény, le democrazie si trovano a un bivio: da una parte, vi è il rischio che esse finiscano per essere sedotte da qualche leader carismatico, pronto a farsi oracolo della volontà popolare; dall’altra, vi è l’opportunità che emergano nuove élite, in grado di correggere i difetti della democrazia rappresentativa senza stravolgerla. Tertium non datur. La seconda strada è ovviamente quella preferibile e forse quella più impervia, implicando un ripensamento dei meccanismi di selezione delle classi dirigenti, un profondo rinnovamento dei partiti, una rielaborazione degli strumenti di aggregazione sociale, una riforma delle istituzioni democratiche e il raggiungimento di un punto di equilibrio tra poteri nazionali e sovranazionali. Non resta che confidare nelle capacità «trasformiste» delle democrazie, che sono state finora in grado di «digerire elementi inizialmente (…) incompatibili» con esse (p. 209).
